Decades of Aggression: aprile 2024
Il 28/04/2024, di Francesco Faniello.
In: Metal Truth, The Birthday Party.
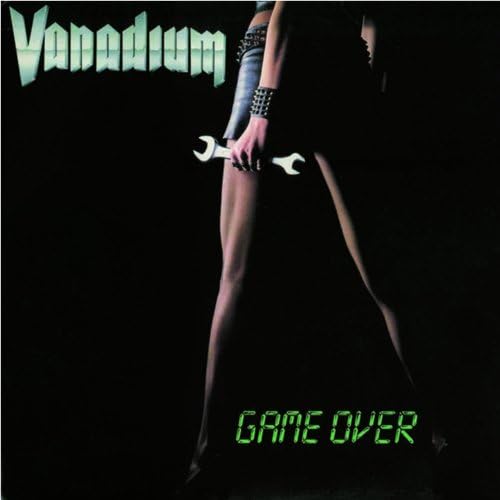
“April is a cruel time
Even though the sun may shine
And world looks in the shade as it slowly comes away…”
Ve l’avevo detto che siamo un po’ tutti blackmoriani dentro. Io, in particolare, che quando arriva la primavera non posso fare a meno di pensare – tra le altre cose – ai lunghi pomeriggi in attesa dell’approssimarsi delle sessioni di esame, spesso scanditi dai novantoni dei Deep Purple: ‘Shades of Deep Purple’ b/w ‘Deep Purple’, ‘Burn’ b/w ‘Stormbringer’ e più tardi, già in pieno dottorato e con meno sensi di colpa sulla testa, ‘In Rock’ b/w ‘Machine Head’. Come vedrete nello svolgersi degli anniversari, il mio richiamo al Profondo Viola non è casuale, data la nutrita schiera di dischi che hanno a che fare con il quintetto dai molteplici Mark, tutti collocati all’inizio del presente articolo. E poi, un po’ di hammond non fa mai male, con questo tempaccio di (maledetta) primavera…
La quota anni ’70 di questo mese è rappresentata da uno di quei dischi che magari non fece il botto al momento dell’uscita ma che decisamente rappresenta un oggetto di culto per i collezionisti di quanto prodotto da Mr. Ronald James Padavona nella sua lunga carriera. Una carriera che può dividersi tra un “prima” oscuro e un “dopo” scintillante, con una cesura che giungerà proprio un anno dopo, coincidente con l’inizio della collaborazione con Ritchie Blackmore. Eppure, le mutazioni repentine non esistono in natura e men che mai in musica: ecco dunque che gli Elf rappresentano il punto di collegamento tra il passato doo-wop e il futuro che vedrà il Nostro primeggiare in ambito hard’n’heavy, diventando una delle voci più rappresentative di questa galassia. ‘Carolina County Ball’ è il secondo di tre dischi usciti sotto questo monicker, edito dalla Purple Records e prodotto da Roger Glover: siamo ancora lontani dal successivo hard rock dai toni epici, ma è indubbio che gli elementi hard boogie che culmineranno nel successivo ‘Trying To Burn The Sun’ qui ci siano tutti, con ovviamente delle linee vocali di sicuro interesse, sia in vista dell’esplosione a venire che riferite al lavoro in oggetto. Poi, anche i sassi sanno che gli Elf erano spesso in tour con i Deep Purple, con il singer che attirò l’attenzione di in un Man In Black sempre più insofferente della svolta funk della band madre e che sarà proprio la formazione presente su ‘Carolina County Ball’ (meno il chitarrista Steve Edwards, ovviamente) a registrare il seminale ‘Ritchie Blackmore’s Rainbow’ l’anno dopo, con l’allora nuovo innesto Craig Gruber al basso che successivamente jammerà con Iommi nel periodo immediatamente precedente all’uscità di ‘Heaven And Hell’. Tra le curiosità riferite a quest’album, c’è la presenza in tracklist di un brano dall’inequivocabile titolo ‘Rainbow’ (un vizio che solo la seconda venuta di Tony Iommi farà togliere all’ugola d’oro dell’Upstate New York, 18 anni dopo), nonché il curioso collegamento tra il ‘Ball’ del titolo e quel ‘Butterfly Ball’ messo insieme dal produttore a cui Ronnie James Dio parteciperà a pieno titolo, qualche mese più tardi…
Aria di anni ’80, aria di casa nostra con ‘Game Over’ dei Vanadium, uno dei dischi più importanti del metal tricolore ottantiano. Terzo album per la band meneghina di Pino Scotto e Steve Tessarin: i riscontri in termini di vendite non mancavano, tanto che sembrava imminente il classico “sfondamento” in Europa, che arrivò solo parzialmente. I motivi? Non è questa la sede più adatta per parlarne; va comunque evidenziato che il sound derivativo dalla lezione di Jon Lord e soci – lezione appresa a menadito da Ruggero Zanolini, vero asso della manica del quintetto – non è di per sé sufficiente a derubricare il fenmeno Vanadium, se si pensa al contemporaneo successo ottenuto dai Kingdome Come (loro sì, autentici cloni – stavolta dei Led Zeppelin). Quello che resta a noi aficionads è un lotto di tracce che punta dritto al cuore, a partire dall’inno ‘Streets of Danger’, passando per una ‘I’m leaving at Last’ ammiccante a ‘The Mule’ di-chi-sapete-voi, per l’impegnata ‘War Trains’, la scatenata ‘Pretty Heartbreaker’ e lo strumentale ‘The Hunter’ (entrambe in bella mostra di sé sul successivo live ‘On Streets of Danger’) ma soprattutto per la ballad ‘Don’t Let your Master Down’, che ho sempre considerato la versione nostrana di ‘Beyond the Realms of Death’ dei Judas Priest. Ebbi particolare fortuna a recuperarne il vinile a quasi quindici anni dalla pubblicazione e tuttora ne apprezzo il potenziale enorme, assieme almeno ai due precedenti ‘Metal Rock’ e A Race with the Devil’. Curiosità: se avete notato una particolare analogia con la copertina del primo EP dei Ratt, beh… è tutto merito della modella Grazia Zuliani, anche performer sul palco nel tour successivo. Con tanto di chiave in acciaio al vanadio, ovviamente.
Se è vero che nello speciale di gennaio ho inopinatamente saltato ‘Slide it in’ dei Whitesnake (nella versione che ho in casa, quella britannica della Liberty), è altrettanto vero che nel mese di aprile cade il quarantennale dell’edizione più nota e di successo dell’album, quella americana, per cui… poco male, pur prediligendo personalmente le sonorità albioniche della band, rappresentate dal baffetto e dal cappello di Micky Moody. Proprio quello stile era ormai il pomo della discordia, con Coverdale che corteggiava esplicitamente Sykes nel tour con i Thin Lizzy tanto da mettere in imbarazzo il vecchio compagno d’arme Moody, il cui sound era legato a quella versione hard/blues della band che aveva tenuto banco fino al precedente ‘Saint & Sinners’. Capita l’antifona, il buon Micky lasciò a fine tour, venendo sostituito nella versione americana proprio dal funambolico John Sykes; stessa sorte toccò al neoarrivato bassista Colin Hodgkinson, estromesso dal ritorno di Neil Murray. Il resto della formazione vedeva Cozy Powell alla batteria oltre al veterano Jon Lord, ai suoi ultimi giorni con il Serpente Bianco data l’incipiente reunion dei Purple. Con o senza gli steroidi a stelle e strisce, ‘Slide it in’ è chiaramente il primo disco del nuovo corso dei Whitesnake, in un’ideale trilogia che culminerà con i superpatinati e pluripremiati due album successivi ma che qui già mostra l’appeal ideale a conquistare i palchi e le frequenze di Oltreoceano – incluso un prestigioso slot al Rock in Rio, con la band ormai in versione quartetto. In effetti, le scalette live della seconda metà degli anni ’80 vedranno quest’album come “anno zero” della band, a parte le riedizioni dei classici in nuova versione e l’onnipresente ‘Ain’t no Love in the Heart of the City’: il lavoro si regge su due o tre singoloni arcinoti (e anche qualche filler di troppo, ridondante sia musicalmente che dal punto di vista testuale), ma personalmente mi sento di menzionare sia quello che è il pezzo più “old style” del lotto, l’opener ‘Gambler’ forte di quei crescendo che solo Coverdale sa regalarci, sia l’intensa ‘Standing in the Shadow’, grande fonte di ispirazione per una serie di band neo-AOR come i Night Flight Orchestra!
“Now that we Three meet again… thru thunder, lightning and the rain… now the hurdey burdey’s done… and the battle has been won”… ricordo ancora quando leggevo queste righe dal vinile del dirimpettaio, dando un’occhiata semi-terrorizzata alla copertina in negativo del successivo ‘Possessed’. Nel diciottesimo secolo John Gay redigeva la Beggar’s Opera, cui fece eco la Dreigroschenoper di Brecht, dando voce ai reietti e agli straccioni. Ecco, la pubblicazione di ‘At War with Satan’ ha sostanzialmente lo stesso sapore, sin dalla beffarda citazione di compimento del Macbeth shakespeariano fino alla lunga suite che dà il titolo all’album occupandone l’intero lato A. Dovette sembrare ben strano ai fan dei Venom trovarsi dinanzi a un minutaggio ben più consono ai loro fratelli o cugini maggiori amanti del progressive del decennio precedente, e non a caso lo stesso Cronos aveva dichiarato che la loro era una risposta all’operato dei Rush, o qualcosa di simile. Anche noi, che prestiamo ascolto alle parole di Cronos, però… Personalmente la title track di quest’album è imperdibile nel suo intento apparentemente contraddittorio: mettere su un’accozzaglia di riff mitologici per creare il prog degli straccioni, su cui il nostro eroe bercia le sue invettive con un basso più arrotondato che mai e denso di gain, Mantas sciorina assoli da Pasquetta avvinazzata e Abbadon dà finalmente un senso compiuto alle sue ritmiche sconnesse, non essendo per una volta obbligato a seguire lo stesso ritmo per più di un paio di battute. Se poi non vi basta, sul lato B ci sono ‘Rip Ride’, ‘Cry Wolf’ e ‘Stand Up (And Be Counted)’. Mai più senza.
Per tutti quelli che si chiedono da dove siano spuntati fuori The Halo Effect, ecco la risposta: dal primo album degli In Flames! Jesper Strömblad allora era il leader della compagine votata a inserire i più disparati elementi del folk scandinavo in ambito extreme metal e con un occhio agli amatissimi Iron Maiden, prima ancora che Gothenburg divenisse la croce e delizia degli esegeti del metal nordico. Soprattutto, su questo disco il buon Jesper suonava la batteria mentre alla voce c’era il fido Mikael Stanne, che poi si scambierà di posto con il futuro “incedibile” Fridén, allora con i Dark Tranquillity. Un album dal fascino indiscusso, che non può fare a meno di incitare all’air violin su episdi come ‘Starforsaken’ ma che ha il suo primo, piccolo classico in ‘Behind Space’ [sic], non a caso poi ripresa un po’ di dischi più tardi.
Da un ascolto veloce della discografia targata The Offspring avevo tirato fuori un pattern secondo cui i dischi “buoni” siano quelli dispari, laddove i “pacchi” siano da ricercare in quelli “pari”. Uno schema opinabile e basato quasi sul nulla, che però mi ricorda che dovrò prima o poi risentire il primo, omonimo album, che mi aveva fatto una così buona impressione, all’epoca. Neanche a dirlo, ‘Smash’ è il loro terzo album: un successo dirompente, figlio dell’ondata grunge che a sua volta doveva molto alla tradizione punk rock e che ora stava restituendo il favore prima ai Green Day e poi al quartetto guidato da Dexter Holland e Noodles, qui responsabile di uno dei bestseller dell’epoca. Tra un’opener al fulmicotone come ‘Nitro (Youth Energy)’ e una serie di singoli in heavy rotation su MTV come ‘Self Esteem’, ‘Gotta Get Away’ e ‘Come out and Play’, è proprio quest’ultima a rappresentare per me uno dei manifesti di quella stagione, con il suo flavour arabeggiante che mostra come sciorinare una scala minore armonica senza bisogno di ore e ore di studio…
Nel 1994/1995 il rito della domenica sera consisteva nel tirare tardi per intercettare la versione europea di Headbangers Ball su un qualche canale tipo Antenna 3 che trasmetteva larghe porzioni della programmazione di MTV; una volta finita la sigla di chiusura del programma di Vanessa Warwick, riprendeva l’heavy rotation di video commerciali. Con due importanti distinguo avvenuti in due distinti momenti e che avevano il sapore del fortino conquistato dagli indiani: uno rappresentato da ‘Train of Consequences’ dei Megadeth, l’altro da ‘Staring Through the Eyes of the Dead’ dei Cannibal Corpse. Incredibile… a notte fonda eppur fuori dai confini in cui il mainstream relegava l’eternamente pericoloso heavy metal. A parziale spiegazione di questa curiosa secondo digressione c’era sicuramente il successo ottenuto da Ace Ventura, e tuttavia non bisogna dimenticare che ‘The Bleeding’, quarto disco della compagine sorretta da Mazurkiewicz e Webster nonché ultimo con Chris Barnes alla voce, è tuttora l’album di maggio successo dei floridiani. Il merito non è solo di Jim Carrey – ci mancherebbe – ma anche di una tracklist particolarmente ispirata, che trova in ‘Fucked with a Knife’, ‘Stripped, Raped and Strangled’, ‘Return to Flesh’ e ‘Force Fed Broken Glass’ una serie di punti di forza che la maggior parte delle band brutal death metal non raggiunge nel corso di un’intera carriera. Oltre alla già citata opener, ovviamente, forte di un videoclip che condivide piacevolmente le atmosfere (e le tematiche?) di ‘Dance of the Dead’ dei C.O.C.!
Se non avete ancora capito qual è la differenza tra ‘Liar’ della Rollins Band, ‘Babe I’m gonna Leave You’ dei Led Zeppelin e ‘Glory Box’ dei Portishead, il merito è di una band incredibile che risponde ai nomi di Chris Haskett (chitarra), Melvin Gibbs (basso) e Sim Cain (batteria) e che qui accompagna il nostro corpulento istrione con il Sole tatuato sulla schiena: un combo dal piglio jazzistico che rende ‘Weight’ la cosa migliore pubblicata da Henry Rollins nel corso della sua carriera musicale, Black Flag compresi. E vorrei ben dire, con tracce come ‘Disconnect’ e ‘Step Back’ a corollario e a far bella mostra di sé nelle scalette live e nella programmazione delle radio indipendenti. “La donna quando non capisce si innamora”, recitava un vecchio adagio: anche l’ascoltatore, aggiungerei. Ah, quasi dimenticavo la coda à la ‘Comfortably Numb’ del singolo citato in apertura: non manca nulla, insomma.
Nello stesso giorno di ‘The Bleeding’ e ‘Weight’ usciva un disco destinato ad ancora maggior fortuna. Si tratta di ‘Live Through This’ delle Hole, uscito peraltro a un pugno di giorni di distanza dalla morte di Kurt Cobain. Ora, se ‘Pretty on the Inside’ è l’album ostico che neanche gli elitisti si fanno pena di fingere di avere ascoltato, se ‘Celebrity Skin’ è l’emblema del successo raffinato della seconda metà del decennio, ispirato com’è dalla figura del redivivo (nella vita della Love) Billy Corgan, se il resto della carriera della band (o della leader, cambia poco) è costellata da episodi di costume come ‘America’s Sweetheart’ o ‘Skinny Little Bitch’, allora ‘Live Through This’ è decisamente l’altra faccia di ‘Nevermind’. Non per dire, eh… le illazioni sulla mano di Kurt su questo disco si sprecano e la verità non la sapremo mai, con buona pace di Mike Broomfield. Eppure, non si resta indifferenti dinanzi alla sbilenca parata di ‘Miss World’, alla sguaiatezza di ‘Doll Parts’ o alla ruvidezza da piede sul distorsore di ‘Violet’. And all the stars were just like little fish…
Strana band davvero, gli americani Pentagram. A leggere la loro storia, sulle prime si è portati a pensare che si tratti di una biografia realizzata ad hoc, un po’ come quella di Alvin e i Chipmunks o degli Spinal Tap. E invece no, è tutto vero: nati negli anni ’70, dopo una serie di singolli e periodi di stop vedono l’approdo al full length solo negli anni ’80, fuori tempo massimo per le atmosfere storiche del doom britannico ma ancora perfettamente in linea con quelle dei loro contemporanei, come Saint Vitus e Obsessed. Questo loro ‘Be Forewarned’ non fa eccezione, in quanto a tempi lunghi e incapacità di capitalizzare uno status “di culto”, un fattore che fortunatamente per loro non tarderà a emergere nei decenni successivi, negli anni d’oro del retro rock. Un disco poco amato dai cultori degli esordi, ma che si incastona perfettamente nelle uscite della Peaceville dell’epoca: è per questo motivo che la label non tarderà a inserirne la title track in bella mostra nel proprio sampler ‘Under the Sign of the Sacred Star’, assieme a My Dying Bride, Annathema e Paradise Lost tra gli altri.
“Hey, wait… I got a new complaint: forever in debt to your priceless advice”. Kurt Donald Cobain (Aberdeen, 20 febbraio 1967 – Seattle, 5 aprile 1994). Come passa il tempo…